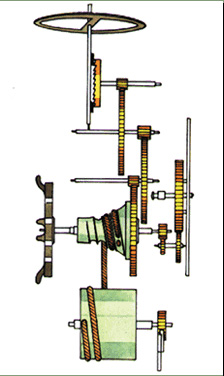ITINERARI - SPAZIO E TEMPO - LA PERCEZIONE DEL TEMPO
LA MISURAZIONE DEL TEMPO
La nozione di tempo nasce dalla capacità di distinguere il prima dal poi, e di sistemare le esperienze vissute in una successione ordinata di eventi, caratterizzati ciascuno da una sua durata. La valutazione della durata di un fenomeno è soggettiva, varia cioè moltissimo a seconda dei soggetti, del loro stato d'animo, della loro cultura, del tipo d'esperienza che stanno vivendo: il tempo «vola» nei momenti interessanti, piacevoli, divertenti della nostra vita e «non passa mai» quando ci troviamo in situazioni sgradevoli o noiose. Come è possibile allora confrontare la durata di due eventi, dire quale dei due è più lungo e di quanto? Anche qui è necessario stabilire un'unità di misura, vale a dire un intervallo di tempo, che chiunque possa misurare senza equivoci e che possa essere considerato lo stesso da tutti, qualunque sia il loro stato d'animo. Occorre cioè trasformare la valutazione soggettiva del tempo in una valutazione oggettiva. Per far ciò bisogna riferirsi ad un fenomeno che avvenga con regolarità nel tempo. L'alternarsi del giorno e della notte e il succedersi ordinato delle stagioni sono appunto fenomeni di questo genere, e il giorno e l'anno sono da sempre le più ovvie unità di tempo. Senonché la precisa determinazione della loro durata è un'operazione tutt'altro che ovvia. Prendiamo ad esempio la durata del giorno, ossia il tempo che la Terra impiega per compiere una rotazione su se stessa. Come possiamo stimare quando la Terra ha compiuto esattamente un giro? Se dovessimo risolvere lo stesso problema con un semplice mappamondo dovremmo prima di tutto scegliere un punto sulla sua superficie, per esempio una città o la vetta di un monte, e poi individuare un punto di riferimento esterno al mappamondo, per esempio la punta di una matita che accostiamo al punto prescelto; poi, tenendo ben ferma la matita, dovremmo far ruotare il mappamondo sul suo asse fino a che il punto torni a coincidere con la punta della matita. Per calcolare un giro preciso della Terra si dovrà fare qualcosa di analogo: il nostro osservatorio sarà l'equivalente del punto segnato sulla superficie del mappamondo, il Sole o qualche altro astro potrà fare le veci della punta della matita. Ecco allora la necessità di osservare con la massima precisione il passaggio degli astri sul meridiano su cui giace il nostro punto di osservazione. Senonché, se prendiamo come riferimento una stella, il giorno (il giorno sidereo, ossia il tempo impiegato dalla stella per ritornare nella stessa posizione nel suo moto apparente attorno al polo celeste) risulta di 23 ore, 56 minuti e 4 secondi, mentre, se prendiamo come riferimento il Sole, il giorno (il giorno solare, ossia l'intervallo tra due successivi passaggi del Sole sullo stesso meridiano, e cioè tra due mezzogiorni successivi) è di quasi quattro minuti più lungo. Diciamo quasi perché la Terra, mentre ruota su se stessa, gira anche intorno al Sole e questo fa sì che la durata del giorno solare non sia perfettamente costante, ma vari un poco nelle diverse stagioni. è necessario allora inventare un giorno convenzionale, il giorno civile, di durata costante, 24 ore, che è la media aritmetica di tutti i giorni solari dell'anno. Come si vede, è sempre l'uomo che, in base alla sua esperienza, alla sua cultura e agli strumenti di cui dispone, giudica del grado di regolarità dei fenomeni naturali. E se questi fenomeni non presentano un grado di regolarità sufficiente ai suoi bisogni, l'uomo può definire unità di misura convenzionali o produrre artificialmente dei processi capaci di misurare il tempo con la precisione voluta. è ragionevole pensare ad esempio che, se facciamo un piccolo foro sul fondo di un recipiente pieno d'acqua, questa ne esca piano piano, con continuità, con regolarità. «Con regolarità» vuol dire che, se ne esce un litro in un certo tempo, il tempo necessario perché ne escano due o tre litri è doppio o triplo del primo. Ma se questo è vero, e se la quantità dell'acqua che esce dal forellino è proporzionale al tempo, misurando la prima si potrà avere una misura del secondo. Questo dell'acqua che fuoriesce da un recipiente forato può sembrare un metodo grossolano per la misura del tempo; e in effetti lo è, se lo paragoniamo ad altri, assai più precisi, che sono oggi del tutto usuali. Esso tuttavia è stato adoperato per centinaia di anni, e fu ancora usato con successo nei primi decenni del Seicento da Galileo, uno dei fondatori della scienza moderna. Un tale metodo permette, infatti, almeno entro certi limiti, di misurare piccoli intervalli di tempo, come quelli richiesti negli esperimenti di Galilei; e soprattutto consente una valutazione oggettiva della durata, perché tutto si riduce a pesare una certa quantità d'acqua, o a calcolarne il volume, operazione che chiunque può fare senza dare luogo ad ambiguità di sorta. Nei suoi Discorsi intorno a due nuove scienze Galileo descrive i metodi e le apparecchiature usate negli esperimenti sulla discesa di sfere metalliche lungo piani inclinati:... Quanto poi alla misura dei tempi, si teneva una gran secchia piena di acqua attaccata in alto, la quale per un sottile cannellino saldatogli sul fondo versava un sottil filo d'acqua, che si andava ricevendo con un piccol bicchiero per tutto il tempo che la palla scendeva [...] Le particelle poi dell'acqua, in tal guisa raccolte, s'andavano di volta in volta con esattissima bilancia pesando, dandoci con le differenze e proporzioni dei pesi loro le differenze e proporzioni dei tempi.